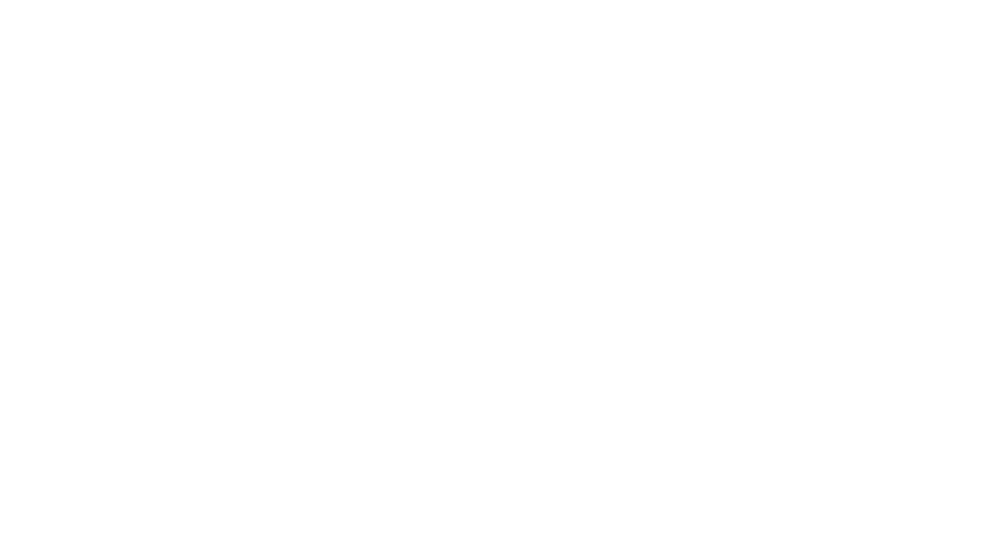INTERVISTA A GIANNI BERENGO GARDIN INTERVISTA A GIANNI BERENGO GARDIN
Dice che tre sono le cose che ama di più: le donne, la cioccolata, e la Leica. E non necessariamente in quest’ordine… Abbiamo incontrato Gianni Berengo Gardin pochi giorni prima dell’evento di consegna del prestigioso Hall of Fame Award, e gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di se e della sua storia di fotografo.
Tu hai cominciato la tua carriera fotografica come fotoamatore, e solo in seguito sei diventato un professionista. Da fotoamatore, chi erano i tuoi riferimenti, i tuoi miti tra i fotografi dell’epoca?
Sicuramente Eugene Smith, ma ancora di più Henri Cartier-Bresson. Quando ho cominciato a fotografare, a metà degli anni ’50, Cartier-Bresson aveva da poco pubblicato il suo libro capolavoro Images à la Sauvette– che io comprai appena uscito nel 1954, e conservo gelosamente ancora oggi – ed era all’apice della propria carriera. Tutti noi, fotoamatori o professionisti, lo vedevamo come un mito; per me era a tutti gli effetti un dio. È stato proprio attraverso quel libro, guardando quelle fotografie, che ho deciso che impronta dare alla mia fotografia e di diventare un fotoreporter.
Cosa avevano di particolare…
In due parole, erano foto vive… Henri ha di fatto rivoluzionato la storia della fotografia, perché prima di lui si fotografava in tutt’altro modo. Io all’epoca, come la maggior parte dei fotografi italiani, usavo la Rolleiflex perché gli editori volevano a tutti i costi disporre di negativi che fossero come minimo di formato 6×6, ma la visione a pozzetto ci limitava dal punto di vista della spontaneità e del dinamismo. Molti altri fotografi – soprattutto in America – lavoravano addirittura con la Speed Graflex e le pellicole a lastra. Lui aveva invece trovato nella Leica – con cui ha creato un binomio inscindibile – lo strumento attraverso il quale sviluppare un approccio totalmente innovativo. E con risultati tali da spingere un’intera generazione di reporter a seguire le sue tracce, al punto che a partire dagli anni ’60 il 24×36 si impose come formato quasi unico per il fotogiornalismo. Io alla Leica ci sono arrivato molto dopo, ma da quel momento è stata la mia compagna inseparabile, e lo è tutt’ora.
Negli anni poi siete diventati amici, ti ricordi quando lo hai incontrato per la prima volta?
È successo all’inizio degli anni ’70. Ero talmente in soggezione che non ho nemmeno osato avvicinarmi, figuriamoci parlargli, per gran parte della serata. Poi qualcuno mi ha portato da lui, ma ero talmente intimidito e imbarazzato da non riuscire a dire niente di più che “piacere…”. Poi siamo diventati, nel tempo, grandi amici. Ricordo quello che è stato sicuramente il mio più bell’incontro con Henri, e uno degli ultimi. Fu nel 1995 a Arles, durante i Rencontres de la Photographie. Passai gran parte del tempo visitando le mostre con Henri e Ferdinando. Ad un certo punto, usciti da una mostra, Henri mi chiese se avevo il suo ultimo libro, Carnet Mexicains. Gli risposi che non ero ancora riuscito a trovarlo in Italia, e lui mi prese sottobraccio e mi portò in una libreria lì vicino. Puoi immaginare l’incredulità e lo stupore del proprietario e dei commessi nel veder entrare Cartier-Bresson dalla porta… Bene, chiede il libro, glielo danno, e lui tira fuori i soldi per pagarlo. Il proprietario si rifiuta di accettare i soldi e pretende di regalarglielo. Henri insiste a volerlo pagare, perché voleva regalarlo lui a me. Tira e molla, sono andati avanti per una decina di minuti fino a quando Henri ha ottenuto di pagarlo e il proprietario della libreria di fargli un grosso sconto… Siamo usciti, ci siamo seduti a un tavolino e Henri mi ha scritto una bellissima dedica (“A Berengo, con l’amicizia e l’ammirazione di Henri”): è stato come se mi decorassero con una medaglia d’oro, un riconoscimento che per me è stato più importante di tanti premi che ho ricevuto negli anni.
Alcune delle tue immagini sono diventate delle vere e proprie icone, come quella del vaporetto, che addirittura apre il libro Augen Auf!che Kehrer ha dedicato ai 100 anni di fotografia di Leica. Cosa significa questo per te?
Sono stato onorato e felice di vedere la mia foto aprire quel bellissimo libro, ma le mie foto le ho scattate sempre come semplici foto e non ho scelto io di farle diventare icone, questo è successo grazie al pubblico, nel tempo. La fotografia dell’automobile sulla spiaggia ad esempio a me non piace particolarmente, e ciò nonostante è divenuta la mia foto più famosa. La foto di Venezia scelta come copertina di una mia recente antologia addirittura non l’avevo mai pubblicata, l’ha trovata Roberto Koch facendo l’editing per il libro più di vent’anni dopo.
Forse l’unica foto che ho spinto davvero è quella del vaporetto a Venezia, perché è una che amo molto, ed è oggi al MoMA a New York ed in molti altri musei e collezioni.
Le tue foto sembrano sempre catturare “l’attimo fuggente”. Come ottieni questo risultato?
Tanto mestiere, tanta esperienza, e uno sguardo sempre attento e curioso. Credo nel momento decisivo ma, secondo me, il momento decisivo non esiste di per sé nella situazione che si fotografa. Sei tu, fotografo, che decidi quando è il momento decisivo. E ognuno lo fa secondo il proprio punto di vista. Dipende tutto dal fotografo; perché bene o male è sempre la sua realtà, quella che interpreta e che vuol far vedere agli altri.
Ti consideri un artista?
No, piuttosto mi considero un artigiano. Non ci tengo ad essere un artista. Sono un fotografo e sono un testimone del mio tempo, documento le cose che mi circondano e che vedo. Poi se ci sono critici che decidono che una mia fotografia è un’opera artistica, sono loro che lo decidono, non certo io. Nella mia personale visione la fotografia in generale dovrebbe occuparsi al cento per cento di comunicazione, non di arte. Può essere influenzata da altre arti, questo si, io ad esempio mi sono sempre ispirato alla letteratura. Da ragazzo leggevo Hemingway, Dos Passos, Faulkner e nella mia mente si sono ricreati paesaggi che poi ho ritrovato quando sono andato in America. Così come le mie foto in Francia sono chiaramente ispirate da Simenon.
Al centro della tua fotografia c’è sempre stato l’uomo. Perché?
Perché è il centro di tutto. Ne ho capito il valore fotografando negli anni ‘60 gli operai nelle fabbriche, alle catene di montaggio. L’ho fatto per raccontarne le storie, i drammi, ma alla base c’era il bisogno di difendere la dignità umana. È quella che mi interessa. Quando con Carla Cerati abbiamo fotografato alcuni manicomi italiani, scoprii che cosa fosse la dignità offesa e umiliata del malato di mente”.
Tu, come tutti i fotografi della tua generazione, da Dondero a Scianna e tanti altri, ti sei formato a Parigi. Cosa ha rappresentato per te questa città?
In realtà come ho detto i fotografi che mi hanno ispirato maggiormente all’inizio erano i fotografi americani di Life, come Eugene Smith. Ma andare in America costava una follia, e quindi sono andato a Parigi. Lì ho frequentato Boubat e Doisneau, ma soprattutto Willy Ronis, che è diventato il mio vero maestro.
Che macchine usi? Sempre e solo pellicola?
Sono un sostenitore della pellicola, anche se recentemente ho provato la Leica Monochrom, che essendo in bianco e nero è molto vicina alla mia sensibilità. Ora continuo a fotografare con le mie Leica M7 e M6 a pellicola. Indubbiamente il digitale è stato una grande rivoluzione. La Leica Monochrom che ho usato ha una resa quasi da banco ottico, ma trovo che il digitale sia troppo “perfetto”, ed è qualcosa che non cerco nella mia fotografia. Credo che la pellicola sia ancora più plastica e, cosa fondamentale, genera un negativo, qualcosa di fisico che si può archiviare e che dura nel tempo.
Oggi passo per quello che è contro il digitale, ma in realtà non ho niente contro di esso in sé, quanto contro alcune brutte abitudini nate con esso, come quella di affidarsi in modo eccessivo e sproporzionato alla postproduzione. Tanti fotografano in modo superficiale o comunque disattento perché pensano che dopo si può correggere tutto con Photoshop, mentre una fotografia va costruita correttamente da subito, dal momento in cui si poggia l’occhio sul mirino.
Quali elementi definiscono una bella fotografia?
Non amo le “belle” fotografie. Le belle fotografie sono completamente inutili, secondo me. È una cosa che ho imparato. Pensavo anch’io “che bella fotografia”, poi una volta quando ero ancora molto giovane sono stato da Ugo Mulas, e mentre lui mi mostrava i suoi scatti io continuavo a dirgli “che bella questa fotografia”, “questa è bellissima”. Più lo facevo, più lui si alterava. A un certo momento mi ha detto: “Se dici ancora che è bella una mia fotografia, io ti caccio fuori”, al che, imbarazzato, gli ho chiesto: “Scusi Maestro, ma cosa devo dire per esprimere il mio apprezzamento? E lui mi ha risposto: “devi dire che sono buone”. Le fotografie belle sono esteticamente perfette, ben composte, che però non dicono niente. Una buona fotografia racconta e dice delle cose, comunica qualcosa. Anche la bella fotografia comunica, ma comunica cose inutili”. Da allora non ho detto più “bella fotografia” ma “buona fotografia”.
La fotografia è forma o sostanza?
Entrambe, fino a un certo punto. Io amo raccontare una storia, come mi ha insegnato il mio amico Koudelka. Sono molto amico con lui e con Salgado e da Koudelka ho imparato che in una fotografia ci deve essere sempre qualcosa da raccontare, mentre da Salgado ho imparato che il contenuto deve andare di pari passo con la forma. Se devo scegliere fra una foto formale e una di contenuto, io scelgo sempre quella di contenuto, ma se a una fotografia di contenuto aggiungiamo la forma ne facilitiamo la lettura. Le due cose dovrebbero quasi sempre andare insieme, anche se il contenuto, per me, resta più forte.
Una volta hai detto: “Il vino è rosso e la fotografia è in bianco e nero…”
In realtà per quindici anni ho fatto il colore per il Touring Club Italiano ma solo paesaggio e architettura: il reportage l’ho fatto sempre e solo in bianco e nero.
Il bianco e nero ce l’ho nel sangue. Il cinema, quando ho iniziato a fotografare era in bianco e nero, la tv era in bianco e nero, i grandi fotografi che ammiravo fotografavano al 99% erano in bianco e nero.
Non ami fotografare le donne…
In realtà credo che le donne non amino essere fotografate da me… Una volta ho fotografato Anna Magnani: eravamo accanto a una finestra e le ho chiesto se potevamo spostarci, perché c’era una luce troppo dura che le sottolineava le rughe. Lei mi ha risposto: “Queste rughe me le sono conquistate, una alla volta, e voglio che si vedano tutte!”. Mi ha sorpreso, e l’ho ammirata.
Comunque faccio pochissimi ritratti in generale, mentre mi piace il ritratto ambientato, dove le persone sono immerse nel proprio contesto.
Il Leica Hall of Fame Award che Leica Camera ti ha tributato quest’anno è un ulteriore riconoscimento che celebra la tua grande carriera e il tuo ruolo nella storia della fotografia. Che consigli ti senti di dare ai giovani fotografi, che questo cammino stanno iniziando a percorrerlo?
Sono stato molto onorato della scelta di Leica di tributarmi questo premio. In realtà, non so se me lo merito… Quanto ai giovani, ognuno deve trovare la propria strada, e credo che se si hanno delle idee, prima o poi, ce la si farà. Non ho insegnamenti da dare perché non ho la presunzione di essere un artista, e non ci tengo a esserlo. Sono un fotografo, ho fatto bene il mio lavoro. Nient’altro.